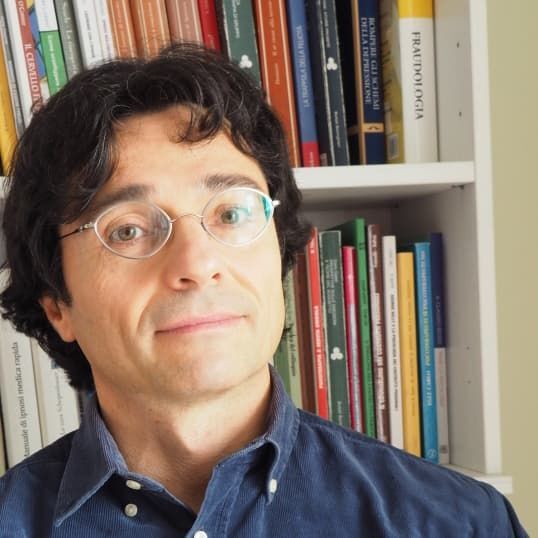Cos’è la sindrome di Stoccolma? Significato e caratteristiche
Con “sindrome di Stoccolma” ci si riferisce a quell'esperienza psicologica paradossale in cui l’ostaggio sviluppa dei sentimenti positivi di affetto, o addirittura di innamoramento, nei confronti del suo o dei suoi sequestratori. Questi ultimi ricambiano i sentimenti positivi verso la vittima e così tra essi si instaura un legame solidale, una sorta di alleanza. Inoltre, chi è affetto dalla sindrome di Stoccolma sviluppa sentimenti negativi verso la polizia e chiunque cerchi di liberarlo dal sequestro.
Il paradosso sta nel comportamento della vittima, la quale dimostra simpatia, fiducia e attaccamento e si sottomette completamente ai sequestratori, nonostante gli eventuali maltrattamenti subiti inizialmente, mentre ci si aspetterebbero dei sentimenti di avversione e la volontà di non assoggettarsi.
Secondo le statistiche dell'FBI, in circa l'8% dei casi di sequestro di persona si osserva il fenomeno della sindrome di Stoccolma.
È bene specificare che la sindrome non si limita ai casi di rapimento, ma si estende a qualsiasi privazione della libertà personale e ad altre forme di violenza, come in caso di “sequestro domestico”. In alcune persone che hanno relazioni con psicopatici si osserva lo sviluppo di attaccamento patologico e dipendenza affettiva, con la convinzione che il partner è indispensabile per la propria sopravvivenza. In questi casi, si può presentare la sindrome di Stoccolma nei confronti del partner, o dell’ex-partner dopo la fine del rapporto.
Origine del nome
La sindrome di Stoccolma deve il suo nome a un fatto di cronaca del 1973.
Due detenuti evasi dal carcere di Stoccolma rapinarono una banca e presero in ostaggio quattro impiegati, tenendoli nei sotterranei dell’edificio per ben sei giorni. Durante la convivenza, tra gli ostaggi e i sequestratori crebbe un sentimento di affetto reciproco. Mentre uno dei due criminali si arrendeva, prima di essere arrestato, gli ostaggi lo abbracciarono pregando la polizia di non fargli del male.
Inoltre, gli ex-ostaggi cercarono di difenderli durante il processo e, dopo che i rapinatori furono incarcerati, gli fecero visita più volte. Addirittura, una di loro divorziò dal marito per sposarsi con uno dei due rapinatori.
Lo psicologo e criminologo Nils Bejerot aiutò la polizia con la negoziazione per il rilascio degli ostaggi durante la rapina. Nei giorni successivi, sottopose i sequestrati a delle sedute psicologiche. Essi dichiararono che avevano paura della polizia ma non dei sequestratori, che questi ultimi "avevano ridato loro la vita" e che si sentivano in debito verso di loro per la loro generosità.
L’espressione “sindrome di Stoccolma” fu coniata in seguito a questo episodio proprio da Nils Bejerot, che la descrisse come una reazione emotiva inconscia al trauma di divenire ostaggio.
È davvero una sindrome?
Anche se si parla di “sindrome”, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) e la Classificazione internazionale delle malattie (ICD) non includono la sindrome di Stoccolma come una patologia mentale a sé stante. Alcuni esperti la considerano una manifestazione dello stress post-traumatico complesso e altri la includono nella reazione acuta allo stress.
Manifestazione e sintomi della sindrome di Stoccolma
I sintomi tipici che si osservano negli ostaggi affetti dalla sindrome di Stoccolma sono:
Simpatia, affetto, fiducia, comprensione, attaccamento nei confronti dei sequestratori
Rifiutarsi di scappare quando si presenta la possibilità
Rifiutarsi di collaborare con polizia ed autorità che cercano di salvarli
Provare paura e sentimenti negativi verso polizia ed autorità
Sottomettersi e compiacere i sequestratori e collaborare con loro
Giustificare e difendere i sequestratori, anche mentendo
Provare sentimenti di colpa nei confronti dei sequestratori quando questi vengono arrestati
Non riconoscere di avere una patologia e rifiutare gli aiuti psicologici
Conseguenze
A liberazione avvenuta, la sindrome di Stoccolma può lasciare un certo malessere psicologico. Tra gli effetti più comuni vi sono disturbi del sonno, incubi ripetitivi riguardo l’esperienza vissuta, fobie, depressione e flashback ricorrenti.
Cause e fattori di rischio
Le cause della sindrome di Stoccolma non sono del tutto chiare. Esistono delle condizioni che ne favoriscono lo sviluppo, quali:
Il sequestro dura a lungo
La vittima ha una personalità poco solida e scarsamente strutturata, non dominante
La vittima è un bambino o un adolescente
I sequestratori si mostrano gentili e cortesi verso la vittima e non mettono in atto alcuna violenza fisica
Il sequestro costituisce una forte minaccia per la vita, non vi sono prospettive di salvezza se non grazie al proprio sequestratore, o non c’è alcuna possibilità di fuga (come nel caso di prigionieri di guerra o di campi di concentramento)
Inoltre, sono state osservate 4 situazioni ricorrenti nei casi studiati, che vengono considerate come i fattori determinanti per lo sviluppo della sindrome. Questi 4 fattori sono:
Sviluppo da parte dell'ostaggio, di sentimenti positivi nei confronti del suo sequestratore
Nessuna precedente relazione tra ostaggio e sequestratore
Sviluppo da parte dell'ostaggio di sentimenti negativi nei confronti di polizia e autorità
Fiducia dell'ostaggio nell'umanità del suo sequestratore.
Aspetti psicologici
La sindrome di Stoccolma è un esempio di legame traumatico, nonché un legame in cui una persona assume una posizione di potere nei confronti dell'altra, la quale diviene vittima di qualche forma di violenza.
Secondo un’interpretazione psicoanalitica, il legame affettivo patologico tipico della sindrome di Stoccolma è un meccanismo di difesa messo in atto inconsciamente per istinto di sopravvivenza. In effetti, migliora davvero le prospettive di sopravvivenza degli ostaggi.
Grazie allo studio di questi casi sono state elaborate specifiche misure dalle autorità che si occupano di negoziare il rilascio, mirate a creare legami emotivi positivi tra il sequestrato e il sequestratore, come richiedere un controllo della salute della vittima o fargli fare una telefonata.
In questo modo viene ricordato indirettamente al sequestratore che ha piena responsabilità dell’ostaggio e le prospettive che il sequestro si risolva positivamente migliorano.
Alla base della sindrome di Stoccolma, ci sarebbe anche la dipendenza affettiva verso il carnefice, che può anche essere vista come espressione dell’istinto di sopravvivenza e che si manifesta soprattutto in personalità particolarmente deboli.
Lo psichiatra Frank Ochberg, consulente dell’FBI, spiega: «Quando un ostaggio pensa che morirà vive una sorte di infantilizzazione: infatti, come un bambino, non può mangiare o andare in bagno senza permesso. In questa fase estrema, qualunque concessione da parte di chi lo minaccia suscita enorme gratitudine; al punto che alla fine, negando a sé stesso la verità, il prigioniero pensa di dovere a un criminale la sua stessa vita».
La sindrome di Stoccolma si divide in fasi
Come prima reazione al sequestro, la vittima sperimenta uno stato di confusione e terrore e di solito si osserva la “negazione”: per sopravvivere, non crede a ciò che sta avvenendo, o addirittura perde i sensi.
La sindrome di Stoccolma presenta tre fasi:
- Circa 3 giorni dopo l’inizio del sequestro, compaiono i sentimenti positivi verso il sequestratore. La vittima ha ancora speranza che qualcuno verrà a salvarla.
Questa fase è favorita dal fatto che alla vittima vengono consegnati dei viveri e soprattutto dalla percezione che il carnefice potrebbe tante cose terribili ma non le fa. La vittima apprezza di non essere maltrattata dal suo sequestratore, il quale appare ai suoi occhi come dotato di umanità. Se invece ha subìto delle violenze, si convince che queste erano necessarie per tenere sotto controllo la situazione o che erano giustificate per il suo comportamento scorretto.
- In seguito, appaiono i sentimenti negativi verso le autorità. In questo momento la vittima inizia a perdere la fiducia verso la polizia che avrebbe dovuto salvarla. Qui spesso viene persa la cognizione del trascorrere del tempo.
Si rinforza l’attaccamento psicologico, in quanto la vittima sente che la sua vita dipende direttamente dal rapitore, il quale provvede ai suoi bisogni primari. Per istinto di sopravvivenza, la vittima sta cancellando inconsapevolmente ogni traccia di rancore verso il suo carnefice. Inoltre, inizia un processo di identificazione:
- vittima e carnefice condividono la stessa situazione di isolamento dal mondo esterno, formano una squadra, si sentono un “noi” (sequestratore e sequestrato) contro di “loro” (le forze di polizia)
- il punto di vista del carnefice diventa l’unico possibile e, così, le sue ragioni vengono “comprese” e viste come legittime dalla vittima.
Nell’ultima fase si instaura una reciprocità di sentimenti positivi tra vittima e carnefice. Questo processo di sensibilizzazione reciproca viene favorito dagli spazi ridotti e dalle frequenti interazioni tra i due.
Il carnefice diventa per la psiche della vittima un alleato per questo evento stressante e viceversa. Infatti, tali sentimenti sono condivisi e non unidirezionali, fatta eccezione il caso in cui il sequestratore soffra di disturbo antisociale di personalità.
Si parla di “sindrome di Lima” quando mente del carnefice scatta un processo di trasformazione da delinquente a salvatore, il quale vuole proteggere e accudire la sua vittima, si preoccupa per lei, mostra empatia, non usa violenza e addirittura le permette di liberarsi.
La sindrome di Stoccolma e la sindrome di Lima possono portare al fallimento del piano di sequestro. Spesso gli organizzatori raccomandano agli aguzzini di avere un atteggiamento violento nei confronti delle vittime e pianificano frequenti cambi degli uomini al loro servizio, in modo che non ci sia tempo di stabilire un legame affettivo tra sequestratore e sequestrato.
È interessante che nei casi studiati, gli ex-ostaggi hanno dichiarato durante le interviste psicologiche di aver “approfittato” del sequestro per passare in rassegna la propria vita e per compromettersi con sé stessi di cambiarla una volta terminata l’esperienza. Il sequestro rappresenta per loro lo spartiacque tra la vecchia vita e una rinascita positiva.
Per riassumere, la sequenza degli stati emotivi di un ostaggio che sviluppa la sindrome di Stoccolma è: incredulità/negazione, speranza/illusione di essere salvato, delusione per la mancata liberazione, rassegna del proprio passato.
Come gestirla?
Non esiste una terapia specifica per la sindrome di Stoccolma.
Il migliore approccio è un aiuto psicologico che accompagni la vittima per tutto il percorso dalla denuncia, al processo, alla rielaborazione dell’esperienza. Anche se difficile, l’interruzione dei rapporti con il carnefice è un elemento importante nella guarigione.
Inoltre, gli esperti concordano che il supporto e l’affetto della famiglia siano fondamentali per il recupero della vittima e il ritorno alla normalità.
IN SINTESI
Cos'è la sindrome di Stoccolma?
È una condizione psicologica in cui la vittima di un sequestro o abuso sviluppa sentimenti positivi verso il proprio aggressore.Quali sono le cause della sindrome di Stoccolma?
Può essere una risposta di sopravvivenza, in cui la vittima cerca di creare un legame per ridurre il rischio di ulteriori abusi.Come si può trattare?
Il trattamento include la psicoterapia per elaborare il trauma e ripristinare il benessere emotivo.
Come può esserti d’aiuto Psicologi Online?
In questa sezione troverai moltissimi articoli che parlano di psicologia, relazioni, sessualità, benessere emotivo e mentale e molto altro, suddivisi in varie categorie.
Oggi ad esempio abbiamo parlato della sindrome di Stoccolma.
Se stai attraversando un momento difficile potresti sentire il desiderio di parlare con uno Psicologo.
Con noi puoi farlo in modo molto semplice. A questa pagina puoi trovare un professionista accreditato (psicologo e/o psicoterapeuta) effettuando una ricerca per città o per problematica da risolvere: www.psicologionline.net/psicologi-psicoterapeuti
Preferisci una consulenza a distanza in videochiamata comoda e accessibile? Con Psicologi Online è possibile.
A questa pagina troverai l’elenco dei professionisti che svolgono consulenza psicologica online:
www.psicologionline.net/psicologi-psicoterapeuti-videoconsulenza
Ti basterà trovare un posto tranquillo, avere una connessione internet e la voglia di comprendere meglio cosa ti sta accadendo.
Ognuno di noi incrocia difficoltà specifiche nel viaggio della vita, a prescindere da chi siamo o da quali “lotte” abbiamo combattuto. Il nostro passato è solo un capitolo del nostro libro, non la trama completa, e non ha la potenza di predeterminare le pagine a venire.
Psicologi Online è qui per questo. Clicca sui link qui sopra per trovare il professionista adatto a te pronto ad aiutarti a stare meglio.
Bibliografia
Kuleshnyk, I. (1984). The Stockholm syndrome: Toward an understanding. Social Action & the Law, 10(2), 37–42.
Biagini, V., Zenobi, S., Vargas, M., & Marasco, M., (2010). La sindrome di Stoccolma: fenomeno mediatico o patologia psichiatrica? Rassegna Italiana di Criminologia, 2, 379-388.
Graham, D.L., Rawlings, E.I., & Ihms, K., (1995). A scale for identifying “Stockholm syndrome” reactions in young dating women: Factor structure, reliability and validity. Violence and Victims, 10(1), 3-22.
Rizo-Martínez, L. E. (2018). El síndrome de Estocolmo: una revisión sistemática. Clínica y Salud, 29, 81-88. https://doi.org/10.5093/clysa2018a12
Strenzt, T., & Ochberg, E.M., (1988). La syndrome di Stoccolma. In F. Ferracuti, F. Bruno, M.C. Giannini, M. Ferracuti Garutti (Eds), Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense. Milano: Giuffrè Editore.
Franzini L.R., Grossberg J.M. (1996). Comportamenti bizzarri. Astrolabio Roma.
Gulotta G., Vagaggini M. (1980). Dalla parte della vittima. Giuffrè, Milano.
Micol Trombetta, Massimo Blanco, Carnefici o principi azzurri? I molti volti della sindrome di Stoccolma, 2022, ISF Magazine, Criminologia.
Cantor, C., & Price, J., (2007). Traumatic entrapment, appeasement and complex post-traumatic stress disorder: Evolutionary perspectives of hostage reactions, domestic abuse and the Stockholm Syndrome. The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 41(5), 377-384.
Namnyak, M., Tufton, N., Szekely, R., Toal, M., Worboys, S., & Sampson, E.L., (2008). “Stockholm syndrome”: Psychiatric diagnosis or urban myth? Acta Psychiatrica Scandinavica, 117(1), 4-11.