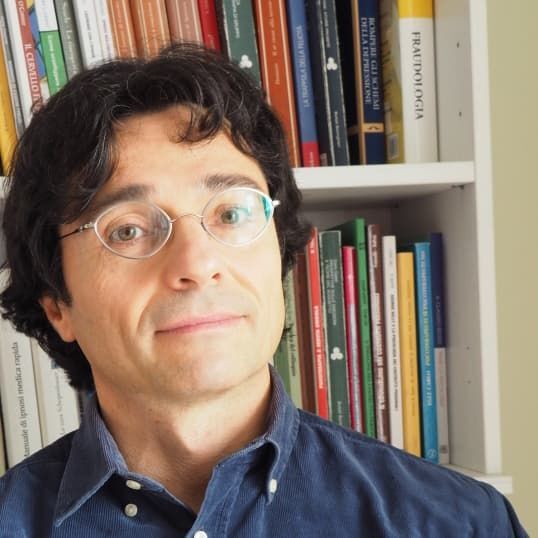Bias cognitivi: cosa sono?
“Bias” è un termine inglese originario del francese e provenzale antico “biais” che significa “obliquo” o “inclinato”.
I bias cognitivi sono fondamentalmente errori del pensiero derivanti da percezioni errate o distorte. Non sono soggetti a giudizio critico e, a partire da essi, si inferiscono giudizi, pregiudizi, stereotipi, ideologie e teorie.
I bias cognitivi sorgono frequentemente in tutti noi come automatismi mentali e ci permettono di prendere decisioni velocemente e senza faticare. Esercitano un impatto significativo sulle nostre opinioni riguardo moltissimi argomenti, sui nostri processi di pensiero e sul modo in cui vediamo il mondo.
Origine del termine
In un passato lontano, il termine “bias” veniva usato nel contesto del gioco delle bocce per indicare i tiri storti. Dalla seconda metà del 1500, il significato di “bias” divenne più ampio e assunse il connotato di “predisposizione al pregiudizio”.
L’origine del “bias cognitivo” risale invece agli anni ’70, quando gli psicologi israeliani Amos Tversky e Daniel Kahneman iniziarono un programma di ricerca di psicologia ed economia chiamato “Heuristics and Bias Program” allo scopo di studiare il processo umano di prendere decisioni in condizioni di incertezza e risorse individuali limitate (come poco tempo e scarse capacità cognitive).
Secondo il modello che i due proposero, l’essere umano segue certe tendenze fondamentali nell’elaborazione delle informazioni e lo fa sempre in dipendenza del contesto in cui si trova.
Poiché il nostro cervello vuole risparmiare tempo ed energia, sceglie di fare “decisioni economiche”, cioè rapide e impulsive, operando con schemi automatici di pensiero e di comportamento.
Questi automatismi mentali a volte possono portarci a commettere errori o delle distorsioni nei nostri ragionamenti, valutazioni e deduzioni. Per esempio, un datore di lavoro potrebbe preferire scegliere un dipendente valutando se “gli piace a pelle”, invece di sedersi e riflettere approfonditamente su ognuna della sua qualità e difetti.
Proprio grazie a queste ricerche, che hanno fortemente influenzato gli studi psicologici ed economici, Kahneman ottenne il premio Nobel per l'Economia nel 2002.
È interessante che oggi i bias cognitivi vengono studiati e sfruttati in molti campi, come nel marketing, per definire avanzate strategie aziendali e mettere in atto tecniche di neuromarketing.
Perché sorgono i bias cognitivi?
Secondo i neuroscienziati Johan E. Korteling, Anne-Marie Brouwer e Alexander Toet, i bias cognitivi derivano da meccanismi cerebrali intrinseci che servono ad orientare il pensiero umano e sono fondamentali per il funzionamento delle reti neurali.
Nel 2000 gli psicologi Martie G. Haselton e David Buss hanno avanzato un'ipotesi evoluzionistica per spiegare la tendenza della mente umana a commettere bias cognitivi. La loro teoria, chiamata "Error Management Theory", afferma che, quando gli svantaggi di un errore sono asimmetrici rispetto ai vantaggi, la selezione naturale creerà meccanismi cognitivi che massimizzeranno l'errore meno dannoso per l'essere umano.
Per esempio, gli uomini credono che le donne abbiano un’attrazione sessuale per loro maggiore di quella che hanno in realtà, per degli errori di valutazione (bias) della comunicazione non verbale: sembra che questo errore abbia portato a vantaggi riproduttivi nel corso dell'evoluzione.
Il bias Blind Spot
Esiste un meccanismo chiamato “Blind Spot” che è un bias che fa da presupposto a tutti gli altri.
Sono stati condotti diversi studi sperimentali per misurare la percezione di bias in sé stessi e negli altri. Ciò che ne è venuto fuori è che gli esseri umani credono di vedere il mondo "oggettivamente" e allo stesso tempo si accorgono dell'esistenza di distorsioni ed errori cognitivi negli altri, ma non in sé stessi.
Secondo gli esperti, esiste un’asimmetria nella percezione dei pregiudizi, detta "illusione introspettiva", che ci porta a credere che noi stessi siamo più obiettivi degli altri. Questo deriva dal fatto che esiste una zona cieca (o blind spot) della nostra consapevolezza che sfugge alla valutazione: quella dei nostri stessi bias cognitivi.
Euristiche e scorciatoie di pensiero
Le euristiche (dal greco “heurískein”, che significa “trovare”), spesso descritte come scorciatoie di pensiero, sono strategie mentali molto rapide, intuitive e sbrigative, che non seguono la logica.
Le euristiche ci consentono di farci un’idea generica su qualcosa, giungere a delle conclusioni, attribuire significato a delle situazioni ed elaborare dei giudizi in modo molto veloce e anche quando non abbiamo molte informazioni a disposizione.
Come nel caso dei bias, si tratta di un metodo di operare che la mente umana ha adottato per elaborare, processare e dare senso a una grande quantità di informazioni in modo più leggero.
Secondo Tversky e Kahneman, le persone prendono decisioni utilizzando un numero limitato di scorciatoie di pensiero, piuttosto che processi razionali. Si ipotizza che le euristiche siano escamotage mentali automatici sorti nel corso dell'evoluzione, che aiutano a raggiungere una soluzione rapidamente e con il minimo sforzo cognitivo.
Le euristiche cognitive funzionano per mezzo di un processo definito “sostituzione dell’attributo”, per il quale inconsapevolmente sostituiamo un concetto complesso con uno simile derivante da esso ma formulato in modo più semplice.
Qual è la differenza tra bias cognitivi ed euristiche?
Le euristiche sono scorciatoie di pensiero che funzionano correttamente in molte situazioni della vita umana, soprattutto nei processi decisionali, ma alterano la percezione di ciò che succede, producendo sistematicamente dei bias cognitivi.
Questi ultimi rappresentano il rovescio della medaglia delle euristiche, nel senso che, per favorire la rapidità e la facilità delle decisioni, portano all’esclusione e al “sacrificio” di certe informazioni rendendoci “ciechi”.
Potremmo dire che i bias sono delle euristiche inefficaci, delle distorsioni del giudizio generate sulla base di errori cognitivi, e non a partire da informazioni tratte dalla realtà.
I bias cognitivi, a differenza delle euristiche, vengono principalmente utilizzati per esprimere dei giudizi, che diventeranno dei pregiudizi.
I bias sono positivi o negativi?
Nei nostri processi mentali e decisionali, facciamo ampio uso di euristiche, violando le leggi della logica. Si tratta di scorciatoie molto utili e generalmente positive nelle situazioni quotidiane, poiché ci permettono di accedere a soluzioni semplici, rapide ed efficaci, riducendo la complessità della realtà e ottimizzando la probabilità di un risultato accettabile.
Sono efficaci soprattutto in determinate condizioni, come mancanza o sovraccarico di informazioni rilevanti o tempo limitato.
Questi meccanismi di pensiero non sono negativi in sé, ma diventano disfunzionali quando si trasformano in pregiudizi rigidi e inflessibili, in errori di valutazione, o quando ci portano ad interpretare la realtà in modo irrealisticamente negativo e a prendere decisioni non ottimali.
I diversi tipi di bias cognitivi
Esiste una tassonomia dei bias cognitivi e delle euristiche, formulata sulla base di una recente ricerca empirica. La suddivisione è in cinque categorie:
Ancoraggio: bias derivanti dalla tendenza ad essere influenzati da un valore numerico di riferimento
Costo: bias legati alla sovrastima del valore dei costi o delle perdite
Desiderio: bias caratterizzati dall'influenza del desiderio nei processi decisionali
Framing: bias caratterizzati dall'influenza del contesto nei processi decisionali
Rappresentatività: bias caratterizzati dalla violazione delle regole probabilistiche a favore delle opzioni più rappresentative e più mentalmente disponibili.
Un’altra classificazione dei bias è quella tra:
Bias inconsci, generati del tutto inconsapevolmente
Bias automatici, che non vengono riconosciuti come tali ma non sono del tutto inconsci
Bias espliciti, che vengono riconosciuti apertamente come tali anche parlandone con gli altri.
I bias cognitivi più comuni ed esempi pratici
Si stima che esistano più di 200 tipi di bias cognitivi e, nel campo della psicologia cognitiva, vengono continuamente identificati nuovi tipi e sottotipi. Ecco alcuni dei bias più comuni:
Bias di conferma: Si verifica quando cerchiamo e valutiamo solo informazioni che confermano le nostre opinioni preesistenti, mentre ignoriamo o sottovalutiamo ciò che non è in linea con le nostre convinzioni. Si tratta di ciò che negli anni ’50 lo psicologo Skinner ha definito “dissonanza cognitiva”, riferendosi al fatto che ci cerchiamo le persone che sono d’accordo con noi e evitiamo quelle che non lo sono. Riferendoci solo alle prospettive che alimentano i nostri punti di vista, potremmo finire per prendere decisioni irrazionali. Ecco degli esempi molto comuni:
Le persone favorevoli alla vaccinazione tendono a cercare su Google “vantaggi dei vaccini”, mentre quelle contrarie “danni e rischi dei vaccini”, in entrambi i casi con il fine di confermare la loro tesi iniziale, illudendosi di informarsi oggettivamente e senza valutare davvero i pro e contro
Una persona che pensa che un determinato partito politico o personaggio pubblico è una persona negativa, tende a prestare attenzione solo alle notizie che riguardano gli scandali relativi a questo
I fanatici di una determinata dieta hanno la tendenza a ricercare quelle informazioni che ne mettano alla luce i vantaggi.
Bias di ancoraggio: Si tratta della tendenza a confrontarci solo con poche informazioni, generalmente le prime che ci vengono fornite, nel prendere una decisione. Detto anche trappola della relatività, fa sì che ci ancoriamo a un valore che poi viene usato come termine di paragone per le valutazioni. Per esempio,
Se ci viene detto che un oggetto, come un telefono, vale 300€, avremo la tendenza a pensare che quello è il prezzo giusto per quel telefono e non negozieremo per un prezzo migliore
Durante una negoziazione, se una persona fa per prima un’offerta a suo favore, avrà buone chances di chiudere la trattativa e fare un ottimo affare.
Bias di gruppo: Ci induce a conformarci alle opinioni delle persone intorno a noi e a sopravvalutare le capacità e il valore di quel gruppo di persone. Per esempio,
I membri di un team potrebbero essere tutti d'accordo su un investimento rischioso solo per non essere visti come quelli in disaccordo.
Bias dell’ottimismo: Si tratta della tendenza a credere che abbiamo più probabilità di sperimentare eventi positivi che eventi negativi. Per esempio
Sono in molti a credere che le loro probabilità di ammalarsi siano inferiori rispetto agli altri
Sul lavoro, è comune pensare che le probabilità di avere successo siano maggiori rispetto agli altri.
Esistono moltissimi altri bias cognitivi che utilizziamo molto di frequente, come il bias del senno di poi, il bias della disponibilità, il bias della negatività, il bias del controllo illusorio e il bias della frequenza illusoria:
- Bias del senno di poi: noto anche come bias della retrospezione, è un errore di valutazione cognitiva che induce le persone a credere, dopo che un evento si è verificato, che avrebbero potuto prevederlo o che era ovvio.
Ad esempio, una persona potrebbe sostenere che "sapeva che la sua squadra avrebbe perso" dopo aver assistito alla partita, anche se prima dell'evento non aveva alcuna certezza sul risultato.
Un altro esempio classico è nei mercati finanziari, dove le persone spesso affermano di "aver saputo" che un particolare titolo o mercato avrebbe avuto un certo comportamento, nonostante la natura estremamente complessa e incerta di tali previsioni.
Il bias del senno di poi può portare a un sovrapprezzo della nostra capacità di prevedere eventi e può distorcere il nostro processo decisionale futuro. Può portare a dare per scontato il risultato di un evento o a sottovalutare i rischi associati a una determinata decisione.
- Bias della disponibilità: è un errore di valutazione cognitiva che porta le persone a sovrastimare la probabilità di eventi che sono facilmente richiamabili alla memoria.
In sostanza, eventi o informazioni che vengono facilmente in mente sembrano più comuni o probabili di quanto non siano in realtà.
Ad esempio, le persone possono sovrastimare il rischio di incidenti aerei perché questi eventi tragici ricevono molta copertura mediatica. Tuttavia, statisticamente, viaggiare in aereo è molto più sicuro che viaggiare con altri mezzi.
Il bias della disponibilità può influenzare la nostra percezione del mondo e distorcere il nostro processo decisionale. Può portarci a prendere decisioni basate su informazioni facilmente richiamabili alla memoria o emotivamente cariche, piuttosto che su dati reali o statistiche.
- Bias della negatività: è un fenomeno psicologico in cui le persone tendono a dare più peso alle cose negative rispetto a quelle positive.
Per esempio, una persona può ricevere numerosi complimenti per un lavoro ben fatto, ma poi rimanere ossessionata da un singolo commento negativo. Questo può avvenire nonostante i feedback positivi siano molto più numerosi dei negativi.
Il bias della negatività può avere profonde implicazioni per la nostra salute mentale, i nostri rapporti interpersonali e le nostre decisioni. Può portare a uno squilibrio nella nostra percezione della realtà, in cui sovrastimiamo i rischi e i problemi e sottovalutiamo i successi e le cose positive.
- Bias del controllo illusorio: è la tendenza a sovrastimare la propria capacità di avere controllo sugli eventi, specialmente quelli che in realtà sono completamente o in gran parte casuali o indipendenti dal proprio controllo.
Ad esempio, una persona potrebbe pensare di avere un controllo diretto sulla probabilità di vincere alla lotteria scegliendo determinati numeri, nonostante il risultato sia in realtà completamente casuale.
Questo bias può avere un impatto significativo sul comportamento e sulle decisioni delle persone. Può portare a comportamenti rischiosi, come il gioco d'azzardo eccessivo, o può influire sulle decisioni finanziarie o di investimento.
Un altro possibile bias di "illusione" è l'illusione di superiorità, in cui le persone tendono a sovrastimare le proprie abilità o competenze rispetto agli altri.
- Bias della frequenza illusoria: L'illusione di frequenza si riferisce al fenomeno in cui una volta che una persona ha appreso qualcosa di nuovo, sembra vedere quel concetto o quell'oggetto ovunque. Questo fenomeno è anche noto come "effetto Baader-Meinhof".
In pratica, l'illusione di frequenza non aumenta realmente l'occorrenza dell'oggetto o del concetto, ma piuttosto la consapevolezza di esso. Ad esempio, se hai appena comprato una nuova macchina, potresti iniziare a notare lo stesso modello molto più spesso.
In realtà, il numero di quelle macchine non è cambiato, sei solo più consapevole di esse perché sono diventate rilevanti per te.
Questo bias può portare le persone a sovrastimare la frequenza o l'importanza di certi eventi o informazioni. Può anche contribuire al bias di conferma, in cui le persone cercano o prestano maggiore attenzione alle informazioni che confermano le loro convinzioni preesistenti.
Come superare i bias cognitivi?
Riconoscere e superare i propri bias cognitivi è importante per prendere decisioni più informate e obiettive, per migliorare le relazioni interpersonali e per proteggersi da influenze sociali tossiche o di bassa qualità.
Ecco dei consigli per farlo:
Nel prendere una decisione considera tutte le fonti disponibili e cerca di raccogliere dati il più possibile oggettivi
Sii curioso rispetto alle informazioni che contraddicono le tue opinioni e confrontati con gli altri
Metti in dubbio le tue credenze e sii aperto a ricevere nuove informazioni e, eventualmente, a cambiare idea.
Sii consapevole dei tuoi pregiudizi e prova a sfidarli. Ricorda che ognuno di noi ha la tendenza a essere influenzato soggettivamente e a crearsi delle convinzioni, che possono portare a errori cognitivi.
Sii disposto ad ammettere i tuoi errori e a imparare da essi.
IN SINTESI
Cosa sono i bias cognitivi?
I bias cognitivi sono distorsioni sistematiche nel modo in cui elaboriamo informazioni e prendiamo decisioni.Quali sono i tipi più comuni di bias cognitivi?
Tra i più comuni ci sono il bias di conferma, l'effetto alone, e l'errore fondamentale di attribuzione.Quali sono gli effetti dei bias cognitivi?
Possono influenzare negativamente il giudizio, portando a decisioni sbagliate o pregiudizi inconsci.Come si possono ridurre i bias cognitivi?
Sviluppare consapevolezza, pensiero critico e imparare a considerare prospettive alternative.
Come può esserti d’aiuto Psicologi Online?
In questa sezione troverai moltissimi articoli che parlano di psicologia, relazioni, sessualità, benessere emotivo e mentale e molto altro, suddivisi in varie categorie.
Oggi ad esempio abbiamo parlato di bias cognitivi.
Se stai attraversando un momento difficile potresti sentire il desiderio di parlare con uno Psicologo.
Con noi puoi farlo in modo molto semplice. A questa pagina puoi trovare un professionista accreditato (psicologo e/o psicoterapeuta) effettuando una ricerca per città o per problematica da risolvere: www.psicologionline.net/psicologi-psicoterapeuti
Preferisci una consulenza a distanza in videochiamata comoda e accessibile? Con Psicologi Online è possibile.
A questa pagina troverai l’elenco dei professionisti che svolgono consulenza psicologica online:
www.psicologionline.net/psicologi-psicoterapeuti-videoconsulenza
Ti basterà trovare un posto tranquillo, avere una connessione internet e la voglia di comprendere meglio cosa ti sta accadendo.
Ognuno di noi incrocia difficoltà specifiche nel viaggio della vita, a prescindere da chi siamo o da quali “lotte” abbiamo combattuto. Il nostro passato è solo un capitolo del nostro libro, non la trama completa, e non ha la potenza di predeterminare le pagine a venire.
Psicologi Online è qui per questo. Clicca sui link qui sopra per trovare il professionista adatto a te pronto ad aiutarti a stare meglio.
Bibliografia
Kahneman, D. & Frederick, S. (2002). Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgement, Cambridge University Press, 2002
Amos Tversky, D. Kahneman (1974) - Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases
Johan E. Korteling, Anne-Marie Brouwer, Alexander Toet (2018), A Neural Network Framework for Cognitive Bias
E. Pronin et al (2002), The Bias Blind Spot: perception of bias in self versus others (PDF) [428 citazioni]
E. Pronin et al (2004), Objectivity in the Eye of the Beholder: Divergent Perceptions of Bias in Self Versus Others
A. Ceschi et al. (2012), Un approccio empirico per una Tassonomia delle Euristiche (PDF) - UNIVR
Lieberman, M. D., Rock, D., & Cox, C. L. (2014). Breaking bias. NeuroLeadership Journal, 5, 1-17.
West, R. F., Meserve, R. J., & Stanovich, K. E. (2012). Cognitive sophistication does not attenuate the bias blind spot. Journal of personality and social psychology, 103(3), 506.
Soll, J., Milkman, K., & Payne, J. (2014). A user’s guide to debiasing. Wiley-Blackwell Handbook of Judgment and Decision Making, Gideon Keren and George Wu (Editors), Forthcoming