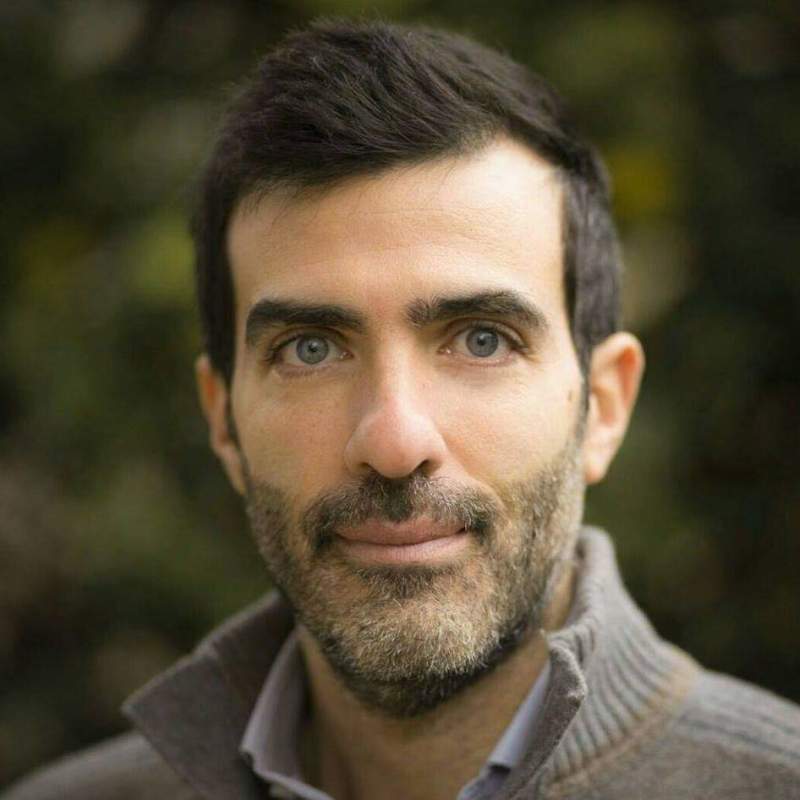Cosa sono i sogni e qual è la loro funzione?
I sogni sono uno stato alterato di coscienza che sperimentiamo durante il sonno, in cui l’attività cerebrale elabora un vero e proprio mondo virtuale che si esprime nella nostra psiche notturna in forma artistica, con immagini, suoni e sensazioni.
Nella storia dell’umanità i sogni sono stati oggetto di studio in moltissimi campi. Le arti, la filosofia, il misticismo, la letteratura, la psicologia, la neurobiologia e la medicina hanno sempre cercato di decifrare il linguaggio dei sogni, e il concetto di sogno è evoluto moltissimo nel corso del tempo.
Nel mondo antico il sogno aveva una funzione premonitrice e serviva a prendere decisioni o a seguire dei consigli che provenivano dal mondo degli Dei. La testimonianza scritta sull’interpretazione dei sogni più antica è il manuale Oneirocritica di Artemidoro di Efeso, che risale al II secolo d.C.
Nel campo della psicologia, i sogni sono un grande strumento introspettivo e il loro valore va ricercato nella loro dimensione simbolica. Il significato che si attribuisce al sogno varia a seconda delle teorie: eccone alcune delle principali in questo ambito.
Nel campo della psicoanalisi, fu Freud a formulare una delle più importanti teorie sui sogni alla fine dell’Ottocento. Egli affermava che il sogno era la via principale per accedere ai contenuti inconsci. Freud concepiva l’atto di sognare come un processo distorsivo in cerca d’interpretazione, all’interno del quale è possibile rintracciare elementi dell’inconscio.
I sogni secondo lui sarebbero un appagamento allucinatorio e camuffato di un desiderio rimosso, cioè un modo in cui i desideri inaccettabili possono esprimersi. Così, durante il sogno l’inconscio libera delle rappresentazioni di contenuti che per la nostra mente razionale e morale sarebbero inaccettabili o minacciosi.
Freud distingue nel sogno un contenuto manifesto, che è facilmente interpretabile perché lo ricordiamo, e un contenuto latente, che racchiude elementi mascherati dall’inconscio. Il sogno contiene informazioni preziose per la ricostruzione di contenuti celati e per la comprensione delle dinamiche inconsce della mente.Jung, discepolo di Freud, invece, credeva che i sogni dovessero essere indagati a livello collettivo e non individuale, e si concentrò sulla ricerca dei simboli dei sogni. I sogni secondo la sua teoria sono l’espressione di un inconscio collettivo, costituito da simboli e immagini archetipiche che tutta la specie umana condivide. Per esempio, è comune sognare alcuni personaggi, come la fanciulla o la sposa, simbolo della purezza, o il vecchio barbuto, simbolo della saggezza.
Jung si discosta dalla teoria di Freud in due punti: il patrimonio archetipico condiviso di cui parla contiene una saggezza profonda che rimanda a significati universali e non a contenuti inconsci personali, e inoltre il sogno non sarebbe un camuffamento di qualcosa che ci viene nascosto ma qualcosa che va interpretato in base ai simboli propri di ogni persona e cultura. Jung descrive una distinzione tra piccoli e grandi sogni, ripresa da dei popoli primitivi: i primi provengono dalla sfera personale dell'individuo, compaiono ogni notte e vengono dimenticati facilmente, i secondi sono pieni di significati e possono essere ricordati anche per tutta la vita per via della forza delle loro rappresentazioni simboliche.Adler considerava il sogno come una di fabbrica di sentimenti ed emozioni che lascia dietro di sé una scia di sensazioni. La sua funzione era quella di allenare il soggetto a vivere esperienze emotive, i cui resti durante il giorno possano apportare un beneficio nella vita. Adler scriveva: “Noi sogniamo e al mattino dimentichiamo i nostri sogni di cui non resta più niente. Ma è poi vero che non resta proprio niente? Restano i sentimenti che i nostri sogni hanno fatto sorgere. Nulla rimane delle immagini, non ci resta nessuna comprensione del sogno, ma solo le sensazioni che esso lascia dietro di sé. Lo scopo dei sogni dev’essere nelle sensazioni”.
Per lo psichiatra svizzero Binswanger il sogno è la nostra patria spirituale, il luogo dove entriamo in contatto con la nostra esistenza, e rappresenta una manifestazione del linguaggio.
Ci sono studiosi, come Hobson e McCarley, che sostengono addirittura che il sogno sia solo un risultato dell’attivazione caotica del cervello e che non abbia alcun significato.
Secondo quanto dimostrato dalle più recenti ricerche nel campo della neurobiologia, i sogni ci permettono di accedere e consolidare contenuti della nostra memoria e anche di elaborare processi già in corso durante la veglia. Grazie alle ultime tecnologie di visualizzazione del cervello come la risonanza magnetica funzionale e la PET, si è scoperto che quando dormiamo, il cervello non riposa, ma cambia la sua funzionalità in alcune aree per garantire le funzioni biologiche e allo stesso tempo restringe il campo di coscienza.
È stato dimostrato che durante il sonno REM, fase in cui si hanno i sogni più vividi, si attivano aree associative del cervello, come la temporo-parietale, la frontale e le limbiche, che sono responsabili delle funzioni mnestiche, semantiche, simboliche ed emozionali.
Il cervello durante il sogno creerebbe così un legame tra le memorie esplicite e implicite e può portare alla luce anche esperienze prive di ricordi coscienti, immagazzinate nella memoria. L’obiettivo è la simbolizzazione, con cui si crea una continuità tra le esperienze emotive passate e presenti del sognatore. Per questo, il sogno va concepito, come una forma di pensiero che ha una continuità con il mondo della veglia, e non come una distorsione di contenuti mentali inconsci. Insomma, la vita del sogno non è molto diversa da quella diurna, solo si manifesta in una forma diversa e ad un altro livello di coscienza.
Significato e tipi di sogni
Il significato dei sogni non può stabilirsi a priori. Se da un lato è vero che nei sogni vi sono simboli e metafore ricorrenti a livello universale, dall’altro lato è anche vero che i sogni non hanno un significato uguale per tutti e che sono influenzati da paure, desideri, esperienze personali e casualità.
Vi sono sogni che sono molto comuni, come sognare di cadere, di perdere i denti o di dover ripetere gli esami di maturità. Questi sogni, oltre ai significati collettivi, assumeranno comunque delle connotazioni personali a seconda del contesto della realtà del sognatore.
Molti simboli sono invece accidentali, cioè legati ad una esperienza vissuta che diventerà simbolo di determinate emozioni per quella persona. In un suo scritto Fromm spiegò questo concetto così: se ho avuto un’esperienza triste in una città e ogni volta che ne sento il nome sto male, la città in sé non ha nulla che fa star male. Se la sogno, è per lo stato d’animo che una volta ho provato in essa. Questo simbolo accidentale, la città, è soggettivo e non può essere condiviso da altri.
Secondo la neurofisiologia, le funzioni dei sogni sono quella di tenere attivo il cervello, consolidare e rafforzare la memoria, elaborare le informazioni. Svolgerebbero un ruolo anche nell’adattarsi allo stress e nella regolazione affettiva. Un’altra ipotesi recente è che l’attività onirica sia un tipo di pensiero che aiuta a organizzare i dati dell’esperienza fino a giungere alla soluzione di problemi.
Secondo la neuroscienziata Cartwright il sogno assolverebbe al ruolo di “regolatore” delle emozioni, attraverso l’integrazione del vissuto della giornata con ricordi passati. A prova di ciò, ha dimostrato che nei soggetti depressi la fase REM è più breve e anche il contenuto dei loro sogni risulta diverso: vengono descritte emozioni appiattite e la percezione della propria persona è come fosse passiva e trascinata dagli eventi.
In linea con ciò, lo studioso del sonno Naiman dell’Arizona University ha evidenziato nei suoi studi come la deprivazione della fase REM di sonno aumenti le risposte infiammatorie dell’organismo, la sensibilità al dolore fisico, le difficoltà di memoria, i comportamenti aggressivi, fino a portare alla depressione. Lui parla di una vera e propria epidemia silenziosa della privazione di sonno REM, che comporta un’inferiore attività onirica e un minor benessere psicofisico.
Una teoria interessante sulla funzione dei sogni è quella dello psicoanalista Fossaghe: i sogni avrebbero la funzione di organizzare l’esperienza, promuovendo l’evoluzione personale, la regolazione e la reintegrazione del Sé.
Vediamo ora quali sono i tipi di sogni:
Incubi notturni: sono i cosiddetti “brutti sogni”, che suscitano paura e portano a svegliarsi bruscamente in uno stato di ansia. Durante queste esperienze, si verifica un’irregolarità cardiaca in fase REM. Freud li chiamava “sogni d’angoscia” e considerava l’angoscia come il sostituito della censura di un desiderio.
Sogni lucidi: mentre in fase REM normalmente la corteccia prefrontale si disattiva e l’esperienza onirica ci sembra reale, durante il sogno lucido siamo consapevoli di stare sognando e possiamo prendere il controllo, per esempio decidere di volare. Durante queste esperienze si è riscontrato un aumento delle onde gamma nei lobi frontale e temporale. Questi tipi di sogni sono oggetto d’interesse di discipline mistiche ed esoteriche.
Sogni sensoriali: comportano delle percezioni con uno o più dei nostri 5 sensi.
Vi sono molti altri tipi di sogni, come quelli allegorici, premonitori, di conferma, psichici, etc.
Ricordare e interpretare i sogni
Molte persone credono di non sognare affatto. In realtà tutti facciamo dei sogni per almeno il 25% del nostro sonno, ma ne dimentichiamo circa il 90%. La capacità di ricordare i sogni deriva da molti fattori:
la fase del sonno in cui ci si sveglia: se è la REM, o se il sogno è mattutino, è più probabile riuscire a ricordarlo
le condizioni del risveglio: nei primi 15 minuti l’assenza di pensieri interferenti, un’alta motivazione e concentrazione aiutano a ricordare il sogno; inoltre, sembra che una sveglia brusca sia favorevole
le caratteristiche del sogno: sogni emotivamente intensi o bizzarri sono più facili da ricordare
la personalità: i soggetti più ansiosi, più creativi e più introspettivi ricordano di più i sogni rispetto alle persone più serie e razionali
l’esercizio: chi tiene un diario dei sogni ne stimolerà la memorizzazione nel tempo
l’ippocampo: secondo uno studio australiano dell’Università Monash chi ricorda i sogni ha dei tempi di disattivazione dell’area cerebrale dell’ippocampo più lenti rispetto a chi non ci riesce.
Una ricerca italiana condotta pubblicata sul Journal of Neuroscience ha dimostrato che i meccanismi utilizzati dal cervello per ricordare i sogni sono gli stessi di quelli impiegati per rievocare fatti accaduti nella vita diurna. Insomma, per il cervello l’accesso ai ricordi episodici è indipendentemente dal nostro stato di vigilanza.
L’interpretazione dei sogni è una pratica molto antica. Già 5000 anni fa in Mesopotamia la Cabala se ne occupava. Tutt’oggi c’è chi si affida alla smorfia napoletana per avere fortuna alla lotteria.
Tra i modi più introspettivi di interpretare i sogni, c’è la psicoanalisi. Freud affermava che “l’interpretazione dei sogni è alla base della psicoanalisi”.
Il lavoro psicoterapeutico sui sogni è estremamente interessante e permette comprendere la natura psichica del paziente. L’interpretazione dei sogni è un’esperienza relazionale, compiuta insieme da paziente e terapeuta, e può condurci in profondità nella parte più nascosta e profonda della nostra mente.
IN SINTESI
Cosa rappresentano i sogni?
I sogni sono espressioni dell'inconscio e possono riflettere desideri, paure o esperienze personali.Come si possono interpretare i sogni?
L'interpretazione dei sogni richiede di considerare simboli, emozioni provate e contesto personale.Cosa fare se un sogno si ripete spesso?
I sogni ricorrenti possono indicare conflitti interiori non risolti o temi importanti da affrontare.
Come può esserti d’aiuto Psicologi Online?
In questa sezione troverai moltissimi articoli che parlano di psicologia, relazioni, sessualità, benessere emotivo e mentale e molto altro, suddivisi in varie categorie.
Oggi ad esempio abbiamo parlato dell'interpretazione dei sogni.
Se stai attraversando un momento difficile potresti sentire il desiderio di parlare con uno Psicologo.
Con noi puoi farlo in modo molto semplice. A questa pagina puoi trovare un professionista accreditato (psicologo e/o psicoterapeuta) effettuando una ricerca per città o per problematica da risolvere: www.psicologionline.net/psicologi-psicoterapeuti
Preferisci una consulenza a distanza in videochiamata comoda e accessibile? Con Psicologi Online è possibile.
A questa pagina troverai l’elenco dei professionisti che svolgono consulenza psicologica online:
www.psicologionline.net/psicologi-psicoterapeuti-videoconsulenza
Ti basterà trovare un posto tranquillo, avere una connessione internet e la voglia di comprendere meglio cosa ti sta accadendo.
Ognuno di noi incrocia difficoltà specifiche nel viaggio della vita, a prescindere da chi siamo o da quali “lotte” abbiamo combattuto. Il nostro passato è solo un capitolo del nostro libro, non la trama completa, e non ha la potenza di predeterminare le pagine a venire.
Psicologi Online è qui per questo. Clicca sui link qui sopra per trovare il professionista adatto a te pronto ad aiutarti a stare meglio.
Bibliografia:
Freud, S. (1899b), L’interpretazione dei sogni. In Opere, vol. 2; Bollati Boringhieri, Torino (1967).
Mancia, M. (2004), Sentire le parole. Bollati Boringhieri, Torino.
Antonio Ferrara, Il sogno come esperienza: un messaggio esistenziale per reintegrare le parti alienate di Sé, Il Sogno nell’Analisi Transazionale clinica – Ed. Marotta – Napoli, 1989
Jung C.G., Considerazioni generali sulla psicologia del sogno, in "Opere", Vol. 8, Bollati Boringhieri, Torino, 1976
Jung C.G., L'analisi dei sogni, in "Opere", Vol. 4, Bollati Boringhieri, Torino, 1998
Valentina Sbrescia, LA PSICOLOGIA ANALITICA E LE NUOVE PROSPETTIVE SUL SOGNO, Psico-Pratika N° 99
ADLER, A. (1920), Praxis und Theorie der Individualpsychologie, tr. it. La Psicologia Individuale, Newton Compton, Roma 1983
E. Fromm, Il linguaggio dimenticato, Bompiani, Milano, 1983 (1951)
F., Hefferline R. F., P. Goodman P., Teoria e pratica della terapia della Gestalt, Astrolabio 1971
Giuseppe Ferrigno, Il sogno come comunicazione. Psicol. Indiv., n. 64: 71-85 (2008)
Fossaghe, J., Le funzioni organizzatrici dell’attività mentale del sogno. Istituto per lo Studio Psicoanalitico della Soggettività. Roma, 9 maggio 199
Grey, P. (2004). Psicologia (pp. 178-189). Bologna: Zanichelli
Fossaghe J. (1983). The psychological function of dreams. A revised psychoanalytic perspective, Psychoanalysis and Contemporary Thought, 6, pp. 641-69
Liotti, G., Monticelli, F. (2008). I Sistemi Motivazionali nel dialogo clinico. Raffaello Cortina Editore, Milano
Cristina Marzano, Michele Ferrara, Federica Mauro, Fabio Moroni, Maurizio Gorgoni, Daniela Tempesta, Carlo Cipolli, Luigi De Gennaro, Recalling and Forgetting Dreams: Theta and Alpha Oscillations during Sleep Predict Subsequent Dream Recall, Journal of Neuroscience 4 May 2011, 31 (18) 6674-6683; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0412-11.2011
Weiss 2013 H. Weiss, Dreams in R. Patai (a cura di) Encyclopaedia of Jewish Folklore and Traditions, New York-London 2013, pp. 127-129
M. Kramer, Insights from the “Dream Book” of the Babylonian Talmud [200-500 ce]
Voss, U., Holzmann, R., Tuin, I. & Hobson, J. A. (2009). Lucid Dreaming: A State of Consciousness with Features of Both Waking and Non-Lucid Dreaming. Sleep, 32(9): 1191–1200.